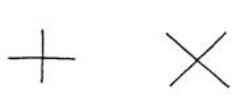Sezione: Lessico
Il fatto che, trattando dei numeri, non ci si occupi dell’unità, potrà anche stupire qualcuno. Ma è una prerogativa esclusiva di Dio quella di essere uno: «Non avrai altro Dio fuori di me» è il primo dei suoi comandamenti. In più, sta anche scritto che Egli non può essere rappresentato: ed è proprio a questo interdetto mosaico che l’iconografia romanica si è sottomessa. Viceversa, un tema che ritorna insistente come un leitmotiv è quello della dualità o della molteplicità che si fonde nell’unità; ne è all’origine ancor sempre il pensiero pitagorico, trasmesso da Boezio e da noi già menzionato, che contrappone «la dualità che genera la molteplicità all’unità che è stabilità». La coerenza e la pregnanza di significati dei primi dieci numeri è tale che il concetto di unità e quello di molteplicità si esprimono alla stessa maniera, attraverso la cifra assoluta investita dai Greci dei sensi più diversi: la X, il dieci romano, segno dell’incrocio, ma al tempo stesso – ed è questa, nella fattispecie, la manifestazione importante – segno della moltiplicazione. Dobbiamo osservare in effetti che ciò che rende meglio di tutto l’idea della Divinità, data l’impossibilità in cui siamo di esprimere l’infinitamente grande, è il punto, l’infinitamente piccolo. Ora, per rappresentare il punto non è la croce diritta quella che più si adatta – essa infatti rende maggiormente sensibile la dualità data dai due assi, verticale e orizzontale –, bensì la croce inclinata.
La figura che cumula questi significati diversi (croce inclinata, Dio assoluto) è quella disegnata dagli animali del Tetramorfo intorno al Cristo – e ciò in entrambe le zone. Il Tetramorfo esprime molto di più la X, l’incognita, l’inconoscibile, che non la moltiplicazione, giacché in questo secondo caso il segno viene tracciato con linee discendenti, mentre i quattro animali formano un segno di croce virtuale, dapprima discendendo verso destra – dall’Uomo al Bue – poi risalendo – dal Leone all’Aquila –, sempre verso destra.
I manoscritti che si rivolgono a dei monaci contemplativi non sempre rispettano quest’ordine imprescrittibile. D’altro canto, l’ordine dei Vangeli non è sempre lo stesso nelle bibbie antiche. Sono i timpani dei portali, specialmente nella zona egiziana, quelli che ne tengono maggiormente conto, e ciò perché il tema, ponendosi come segno d’interdizione all’accesso, come segno iniziatico riservato ai fedeli, concretizza nel modo più corretto le tappe che il cristiano deve superare, alla stessa maniera con cui supera la soglia della chiesa. Attraverso i quattro personaggi che rappresentano un numero quasi infinito di realtà – temperamenti dell’uomo, direzioni dello spazio, elementi dell’universo, ecc. –, i bracci della croce inclinata esprimono la molteplicità, mentre il punto di unità è impersonato dal Cristo centrale. Lo stesso dicasi per la croce inclinata che viene tracciata sull’altare per evocare le cinque piaghe di Gesù sulla croce: l’uomo microcosmo si inserirà nell’universo secondo i due piani così definiti nel rito della consacrazione. Per due volte, infatti, il prete traccia le cinque croci. La prima volta con l’acqua benedetta, l’acqua di vita, che è la stessa del Diluvio, grazie alla quale l’umanità ritorna alla propria sorgente: per cui, simbolicamente, spinto da una volontà di purificazione, egli pone l’accento sul centro, sul punto; la seconda volta con l’olio dei catecumeni, e di conseguenza con intento evangelizzatore: la consacrazione viene a prendere possesso del cosmo purificato e l’accento è posto sui bracci della croce. Analogamente per quell’altra croce che il pontefice disegna – nella navata, in diagonale, scrivendo le lettere dell’alfabeto, nel corso della consacrazione della chiesa nel suo complesso.
L’importanza eccezionale di questo tema della dualità che si fonde nell’unità, del «due in uno», è strettamente legata per entrambe le zone all’essenza stessa delle due fonti. La fonte egiziana corrisponde al complesso del cerchio. L’immagine circolare materializzata sia nel disco alato del sole, con i due serpenti che lo inquadrano, sia nei simulacri realistici degli dèi relegati nella cella (fondo del santuario). Il cerchio ocellato solare, insomma, perdura in modi diversi nella iconografia della zona egiziana. Per contro gli dèi mesopotamici sono volentieri definiti coi loro simboli, e il santuario finisce con l’essere un tempio-montagna, alto, sottratto alla vista degli uomini: a proteggerlo ci sono delle porte possenti e dinanzi ad esse dei leoni che vi montano la guardia. È da questa visione mesopotamica della divinità e dei rapporti con essa che trae origine il divieto ebraico della Legge, ricevuta, si badi bene, da Mosè proprio su una montagna, il Sinai.
Così se si considera che si hanno in generale tre termini per esprimere la Divinità, un dio e due geni, o angeli, che lo accompagnano, la tendenza egiziana è quella di porre l’accento sull’Uno, il dio, mentre quella mesopotamica lo pone sul Due, gli accoliti della divinità. La stessa differenziazione si riscontra nell’arte romanica fra le disposizioni dell’una e dell’altra zona.
Nella zona egiziana i due angeli sorreggono la mandorla del Cristo dell’Ascensione e compongono con lui un’immagine paragonabile al disco alato. Nella zona mesopotamica, invece, i due angeli «annunciatori» spezzano la maestà della composizione e suscitano l’idea del divieto, facendo allusione alla visione che deve venire. In senso inverso, il Tetramorfo del sud est è veramente centrato sulla figura del Cristo; secondo l’osservazione di J. Baltrusaitis, i quattro Animali di quello di Moissac sono come storcignati, e ciò determina la rottura dell’immagine circolare; quella che essi compongono si direbbe piuttosto una palmetta. Nei portali del sud est c’è un incrocio essenziale, ed è quello disegnato dagli Animali. Al contrario, nella zona mesopotamica gli incroci sono molteplici: basta pensare alle gambe degli Apostoli di Beaulieu e dei Vegliardi di Moissac. Ma prendiamo il tema delle tappe: nella zona egiziana si insiste dappertutto sul terzo termine, il più importante; a Compostella e a León questo termine sembra invece relegato nelle parti più alte, come vedremo fra poco, e sono le due allegorie inferiori del leone e delle gambe incrociate a essere le più importanti. Nei portali egiziani la molteplicità è rigorosamente ricondotta all’unità; anzitutto i due temi che costituiscono timpano e architrave. Nei portali eucaristici i due protagonisti del doppio tema copto – quello dell’architrave che evoca la Chiesa militante e quello del timpano che simboleggia in contrapposizione la Chiesa trionfante, ossia la Vergine e il Cristo – richiamano alla mente l’unione dei contrari, dei due principi. Tutto ciò va rapportato, in ogni caso, alle speculazioni più correnti della mistica, che vede in Dio due aspetti opposti – il terribile e il dolce –, ma anche alla unione di due divinità, maschile e femminile, nella ierogamia cosmica: di Keb, per esempio, il dio della terra, e di Nut, la dea del cielo (ovvero di Osiride e Iside), in Egitto, simili peraltro alle coppie di tutte le mitologie, come quella di Isanami e Iganami in Giappone, coppie che sono generalmente all’origine della creazione, ma che la Bibbia non ha ripreso.
Il tipo di portale che È. Mâle ha chiamato eucaristico – per il suo riferimento all’Ultima Cena e al tema eucaristico del pane e del vino: per esempio, quello delle Nozze di Cana a Charlieu, quello della lavanda dei piedi a Condrieu, quello della Moltiplicazione dei pani e dei pesci a Valence, quello della Cena a Champagne (Ardèche), ecc. – insiste sull’unità del Cristo, Verbo incarnato, costantemente presente nel sacramento della Messa attraverso la commemorazione del suo sacrificio che egli ci ha incaricati di rinnovare fino al suo ritorno; e ciò contro l’eresia che si propagava minacciosa nella valle del Rodano, così come nel sud ovest, e che negava appunto il valore dei sacramenti. Facciamo osservare, incidentalmente, che quello di Charlieu è un portale doppio, ma l’esaltazione di questi temi eucaristici sul portale più piccolo – più piccolo, ed è questo che lo distingue, da portali doppi del sud ovest, che per tutto il resto sono uguali –, è messa lì proprio per insistere una seconda volta sull’idea della Chiesa intesa a preparare il Ritorno Finale, la Parusia; secondo il pensiero di Pietro il Venerabile, le Nozze di Cana rappresentano l’opposto dei sacrifici pagani, l’opposto dell’eresia. Gli Apostoli sul portale maggiore, tutti seduti, hanno già la maestà del ruolo di giudici che il Cristo ha promesso loro. La molteplicità è strettamente riportata all’unità della visione tetramorfica, e la stessa cosa è riscontrabile in tutto il sud est.
La composizione è esattamente opposta nelle Ascensioni e negli altri temi dei portali del sud ovest. Il timpano comprende sempre e soltanto un tema, non due, o magari tre: così nella porta del Perdono a León, così sul fianco destro della porta degli Orafi a Compostella: la dualità trova riservata ai due lati o alle estremità dell’architrave, a Saint-Genis-des-Fontaines, a Sorède, o alla porta Miégeville, dove gli Apostoli appaiono diversamente interessati dall’avvertimento dell’angelo; essa è rappresentata altresì dai personaggi dei pennacchi ai lati dell’arco o, a Moissac e a Beaulieu, dei piedritti e delle strombature. Da notare ancora, soprattutto nel Béarn, il timpano suddiviso in due timpani minori. In questo modo, non si può parlare di Due in Uno, ma piuttosto di Uno in Due. Sono i dettagli e il moltiplicarsi dei temi secondari a rendere manifesta la fusione di due realtà in una sola, con una prodigalità e una fecondità pressoché infinite: animali in posizione di «contrasto», personaggi allegorici con le gambe incrociate, temi apocalittici. Ma soprattutto, particolare che risponde meglio alla divisione dell’Uno in Due, è la maschera della Terra, con i suoi occhi fuori delle orbite, con la mancanza di unità prodotta dal mento – aspetto specifico, questo, del T’ao t’ie –, quella che, come sostituto della divinità da cui tutto scaturisce e a cui tutto ritorna, riesce ad esprimere meglio il tema della «illusione cosmica»: questa negazione del mondo reale è tipica, essenzialmente, dei catari e delle religioni dell’Estremo Oriente; ma evidentemente si tratta di una visione che è agli antipodi della dottrina cristiana. Equivalente dell’Uno primordiale, è da questa maschera che, su certi capitelli spagnoli, sbucano fuori gli uccelli e poi gli uomini col leone, secondo i meccanismi dell’Uno in Due, della dualità insita al fondo dei nostri rapporti col mondo – lo stesso «mondo della dissomiglianza» di cui parla san Bernardo e la cui espressione ultima e più caratteristica è l’uomo tagliato in due di Chauvigny.
Oppure è il tema del leone con due corpi e una sola testa – leone che può presentarsi, come nel caso di Bages, proprio con una maschera della Terra, o magari, come a Chauvigny, con quella della Medusa o della Gorgone greca –, a mostrare contemporaneamente la divisione dell’Uno in Due e il ritorno del Due all’Uno: si tratta di una variante dell’uomo col leone, e il passaggio dall’Uno al Due, poi dal Due all’Uno, costituisce il senso stesso della maschera della Terra, dalla quale lo stesso uomo col leone ha origine e alla quale egli fa ritorno.
Il tema dell’unità che si degrada in dualità è presente anche sui portali, e in tutt’e due le zone (quindi anche in quella egiziana), quando il soggetto che vi è sviluppato è quello dei rapporti fra il cielo e la terra; lo troviamo, per esempio – ed è ovvio-nei Giudizi universali, tipo quello di Autun, ma altresì nel caso di Favole, come quelle del terzo livello di Saint-Ursin, e ancora negli archivolti della Charente in cui si fa pure riferimento al Giudizio – parabola delle Vergini sagge e delle Vergini folli, Psicomachia, Agnus Dei –, non meno che in quelli in cui invece è rappresentata la Pentecoste, come a Vézelay e ad Aulnay (portale meridionale). Qui è la presenza del personaggio solstiziale a essere fondamentale, giacché, essendo posto nella chiave di volta, esso viene a segmentare l’anno in due parti: ad Aulnay cinque temi della regolazione cosmica, a Saint-Ursin il mezzobusto del personaggio cornuto, altrove l’uomo accovacciato o i segni zodiacali, tutti vogliono illustrare la dualità che governa il mondo. Ad Aulnay, particolare significativo, il fregio di elementi simbolici ha inizio proprio a partire da questo asse centrale.
Ma nella zona egiziana, al pari di quella mesopotamica, sarà piuttosto l’asse cosmico, sarà l’albero a Y, quello che farà sbocciare meglio l’idea del Due in Uno, favorito dalla sua stessa natura, con i due rami che si dipartono da un unico tronco; e sarà così verso l’alto, non verso il basso, che si vedrà dominare alternativamente il Due o l’Uno: l’Uno mediante il tema isolato della rosetta, del grappolo o del cuore, come in Alvernia, oppure mediante quello del leone, del fiore di carlina o della mano divina, come a Saint-Vincent di Chalon; il Due invece, grazie ai due angoli dei capitelli, mediante i due grappoli strappati dai centauri, ancora in Alvernia, oppure mediante le coppie, le sirene, le figure di Adamo ed Eva, i geni di foglie, le maschere attorno al tirso e così via, ancora sui capitelli di Saint-Vincent a Chalon, ferma restando ovviamente l’insistenza sui due rami dell’albero a Y. Nelle chiese spagnole, lo stesso: saranno delle palmette – doppie nel sud, semplici nel nord – che evocheranno questi due aspetti nelle due parti della chiesa.
Lessico dei Simboli Medievali, Jaca Book, Milano 1989, pp. 214-217